
Il peggio è accaduto. E adesso? Una riflessione sulla vittoria di Drumpf
Come era successo la notte prima che venissero annunciati i risultati del referendum sul Brexit, ieri sera molti di noi sono andati a dormire sperando che la catastrofe si sarebbe evitata. Invece stanotte il peggio è (di nuovo) successo: Donald Trump ha vinto le elezioni americane, diventando così effettivamente il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti, carica alla quale ascenderà ufficialmente a gennaio 2017. La sua vittoria è certamente espressione di un sentimento anti-istituzionale che si è diffuso tra le fasce più svantaggiate delle popolazioni occidentali negli ultimi anni, come reazione alla crisi economica ed alle seguenti politiche di austerità, così come all’incapacità della politica ufficiale di dare risposte valide ai problemi dei cittadini e di coinvolgerli attivamente nel processo politico. Ma si tratta anche del prodotto di un fenomeno parallelo e più preoccupante, ovvero della crisi di un certo senso di identità fortemente radicato nel mantenimento dello status quo dominante: bianco, maschile ed eterosessuale. La vittoria di Trump riflette infatti sentimenti di ansia, paura ed insicurezza vissuti da una parte di elettorato che si vede non solo lasciato indietro da un capitalismo sfrenato, ma anche privato della possibilità di farsi forza di quegli elementi che, in un mondo precedente alle battaglie per i diritti civili (delle donne, delle minoranze sessuali e razziali, di chiunque sia stato storicamente sfruttato o subordinato), permettevano di identificarsi almeno parzialmente con il lato dei “vincitori”. Il fenomeno Trump è rassicurante per chi partecipa di questa incertezza, perché offre l’esempio di un uomo (e che sia uomo e non donna è importante) privo di capacità od esperienza politica, volutamente anti-diplomatico ed anti-intellettuale, il cui unico capitale spendibile in queste elezioni era quello di essere in qualche modo “diverso” dai politici con la P maiuscola, e che ha saputo trasformare quelle che potevano essere viste come gravi mancanze in un punto di strabiliante vantaggio. In questo senso, Trump rappresenta la vittoria di tutto ciò che una parte dell’elettorato che lo supporta sente minacciato: il senso flebile di un privilegio ereditato attraverso la casualità dell’esser nati bianchi ed americani (meglio se maschi): la certezza di far parte, senza alcun impegno o merito individuale, del gruppo dei potenti.
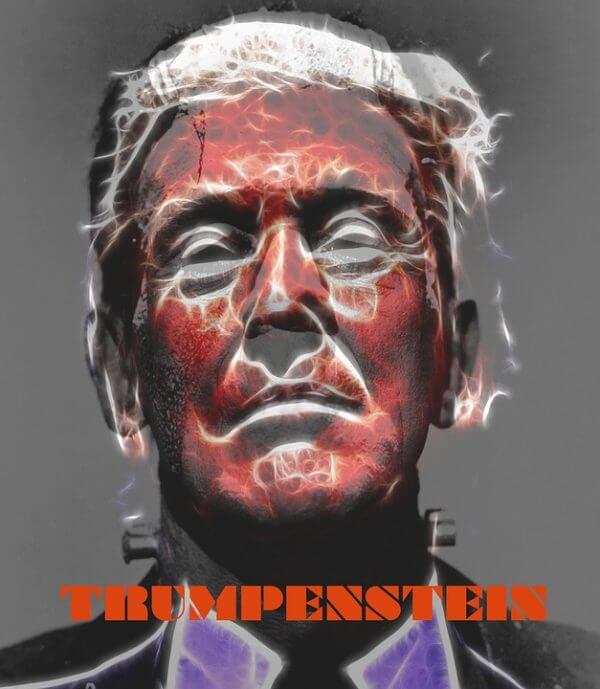
In un articolo uscito stamattina sul New York Times, il giornalista David Remnick insiste sul fatto che Trump ha saputo far leva sul senso di espropriazione ed ansia di milioni di votanti, soprattutto bianchi, fiduciosi nel fatto che il magnate si sarebbe fatto carico dei loro risentimenti, della loro rabbia e della loro sensazione di vivere in un nuovo mondo che cospira contro di loro. Questo elemento (alcuni lo chiamerebbero vittimismo) è cruciale per capire il successo del tycoon, visto da alcuni commentatori delle sinistre americane ed europee come il prodotto dell’insoddisfazione delle classi popolari verso il sistema economico attuale. Se questo è in parte vero, quello che questi opinionisti dimenticano di indagare è il fatto che tale sentimento si è espresso nella preferenza verso un candidato che non risparmia esternazioni e comportamenti razzisti, sessisti ed antidemocratici, finendo per identificarsi con un ideale di purezza nazionale su linee razziali, sessuali e di genere. Piuttosto che su di un genuino sentimento anti-capitalista o anti-establishment, la campagna di Trump ha infatti puntato su una vaga retorica anti-globalizzazione ed anti-liberal che mira soprattutto a difendere ciò che è “nostro” (sicurezza, potere, privilegio e ricchezza) dalla minaccia rappresentata da coloro che a vario titolo reclamano il diritto di condividerne i vantaggi (migranti, donne “maligne”, minoranze razziali e sessuali). Va da sé che tale retorica omette sempre di citare il ruolo che questi “altri” hanno avuto nel produrre e conservare le ricchezze della comunità nazionale (per rimanere nel solo campo economico: il lavoro coatto degli schiavi neri, quello sottopagato dei migranti latini, quello domestico e di cura da sempre svolto in maniera non retribuita dalle donne). Non è un caso che lo slogan della campagna di Trump sia stato “Make America Great Again!”, ovvero “Rendiamo l’America Grande di Nuovo!”, dove il “di nuovo” allude al ritorno ad un passato ed un mondo in cui “noi” (uomini bianchi e potenti, e potenti perché bianchi) eravamo grandi e in controllo, e “loro” (donne, migranti, minoranze di ogni tipo) rimanevano al loro posto, ovvero subordinati. Che il motto di Hillary Clinton “Stronger Together”, ovvero “Più Forti Insieme”, non sia riuscito a convincere una fetta sufficiente dell’elettorato americano a schierarsi con lei, così come non ci è riuscito il supporto del presidente e della First Lady in carica, si deve non solo al fatto che molti la vedono come non necessariamente migliore di Trump, ma anche e soprattutto al prevalere in queste elezioni di una mentalità del “noi oppure loro”, capace di concepire il successo di un certo gruppo di persone sempre e solo a scapito dell’altro.

Come è stato scritto da molti ed in maniere diverse, la vittoria di Trump rappresenta la vittoria di chi non si fa problemi a riappropriarsi in maniera per nulla dispiaciuta o timida del proprio privilegio economico, razziale e di genere. Come spiega Benedetta Pintus su Pasionaria.it “a vincere è stato chi di questo privilegio non si vergognava. Chi, anzi, ne faceva una bandiera. Chi l’ha usato non per blandire, ma per spaventare, dividere, dare voce all’arroganza e imporre la legge del più forte. Niente di nuovo sotto il sole”. Niente di nuovo, già, ma le reazioni sconcertate provenienti da ogni parte del mondo oggi dimostrano che per molti l’elezione di Trump alla guida degli Stati Uniti rappresenta una prospettiva ben più inquietante di quelle cui abbiamo avuto modo di assistere nel panorama politico degli ultimi anni. Il peggio è successo, e la domanda da farsi a questo punto è: e adesso? Come scrive sempre Remnick sul New York Times “la disperazione non è una risposta”. Se Trump ha saputo convincere l’elettorato di classe medio-bassa che si sarebbe preso cura dei suoi problemi è anche perché l’establishment democratico non ha saputo dare lo stesso messaggio rassicurante, fallendo nel coinvolgere ampie fette della popolazione americana oramai estraniata dal processo politico. Quello che ci resta da fare a questo punto è riprenderci dallo shock nel tempo dovuto, e poi tornare a lavoro, continuando a chiedere con maggior forza che i diritti ed i valori che riteniamo importanti vengano rispettati nel futuro che ci attende. Se Trump ha vinto cavalcando l’onda del risentimento, noi possiamo consolarci col pensiero che, parafrasando Albert Camus, “appena diventerà possibile per gli uomini avere il più piccolo frammento di speranza, si può dire che il regno di Trump sarà effettivamente finito”.
Immagine di copertina di Professionell-Pflegende / Pixabay
America, brexit, Clinton, Drumpf, elezioni, featured, Privilegio, US