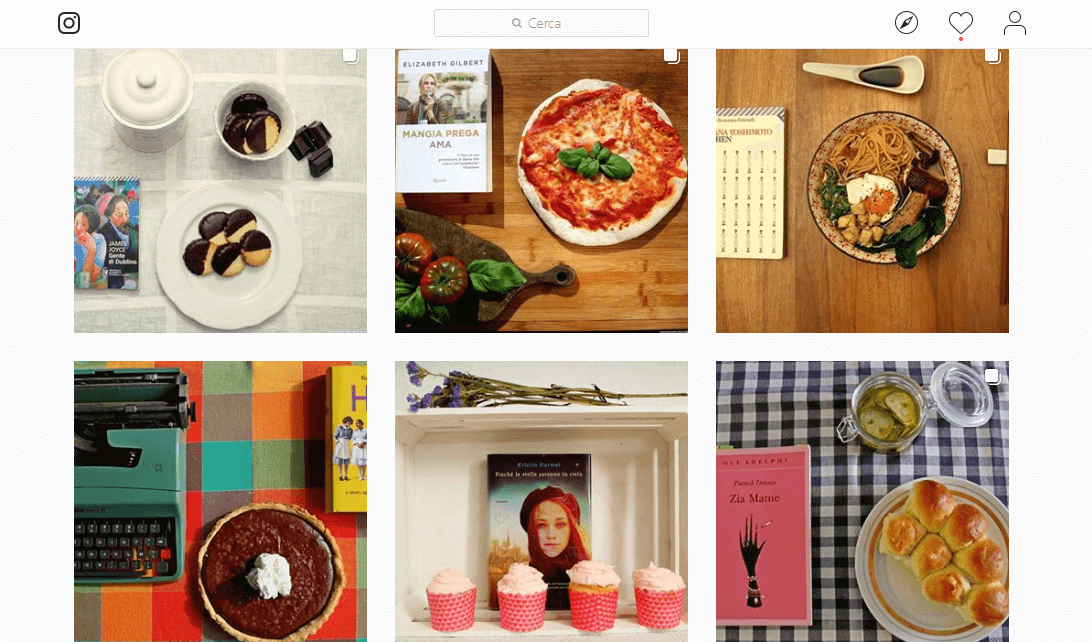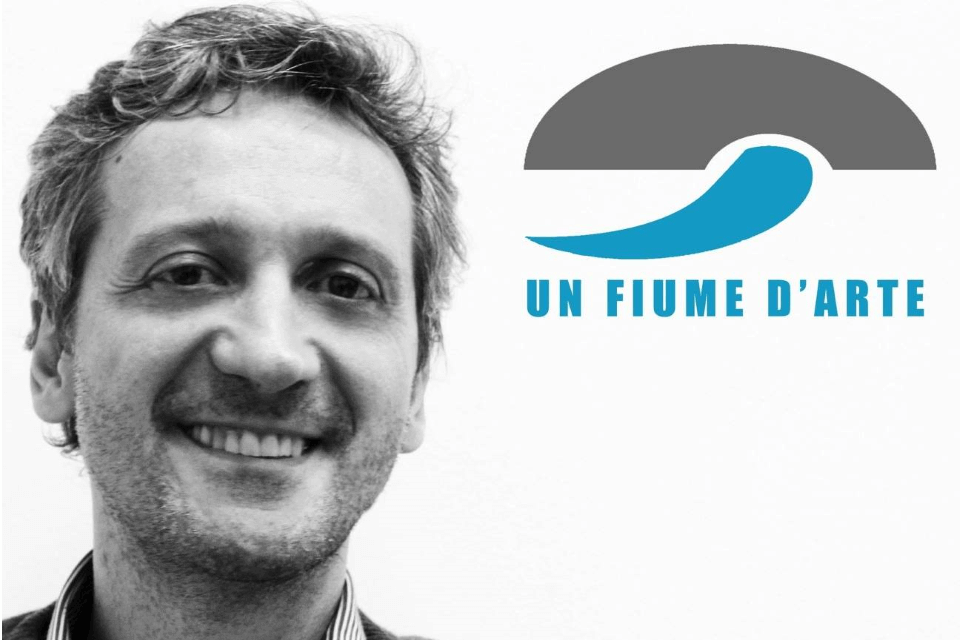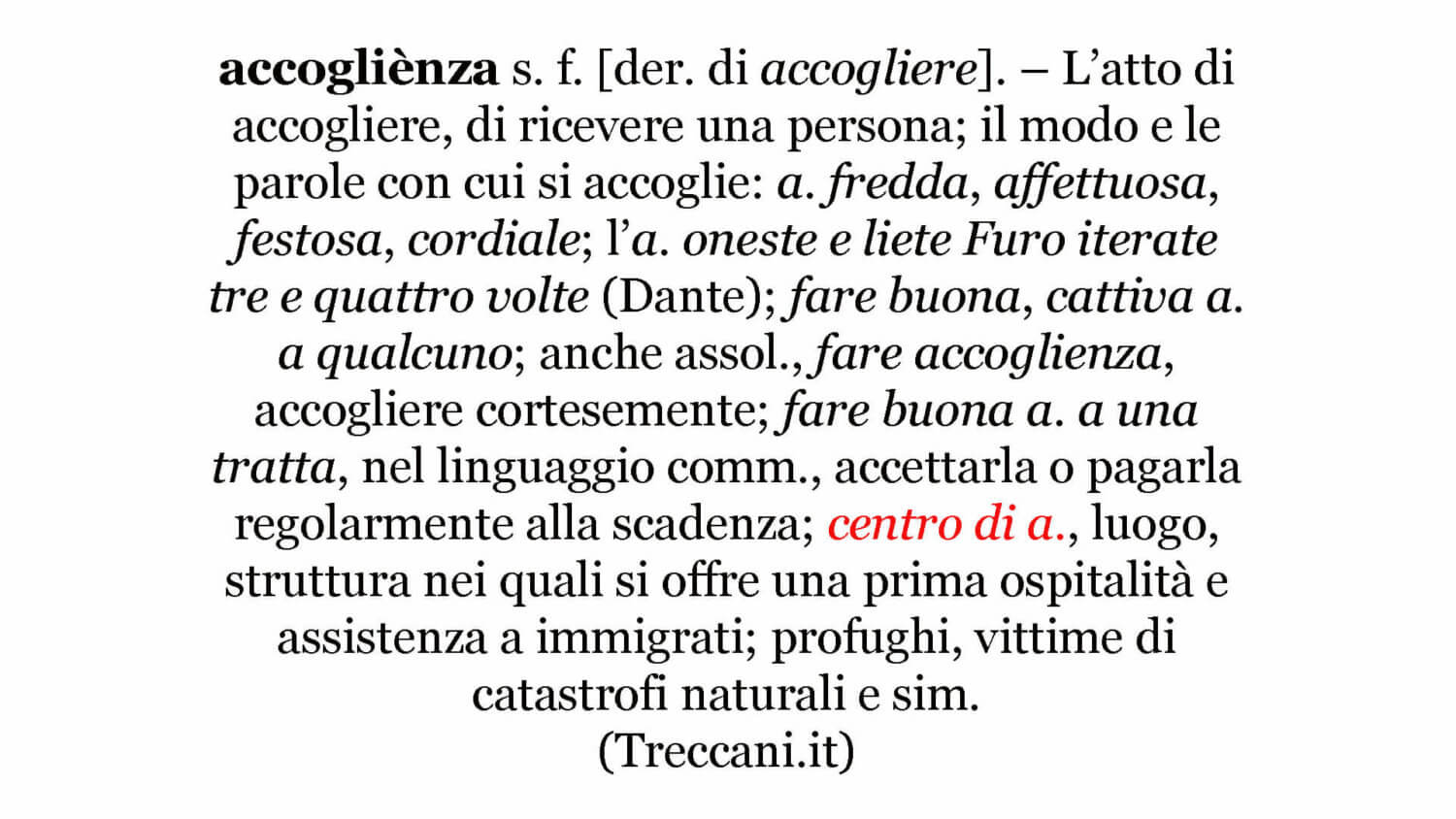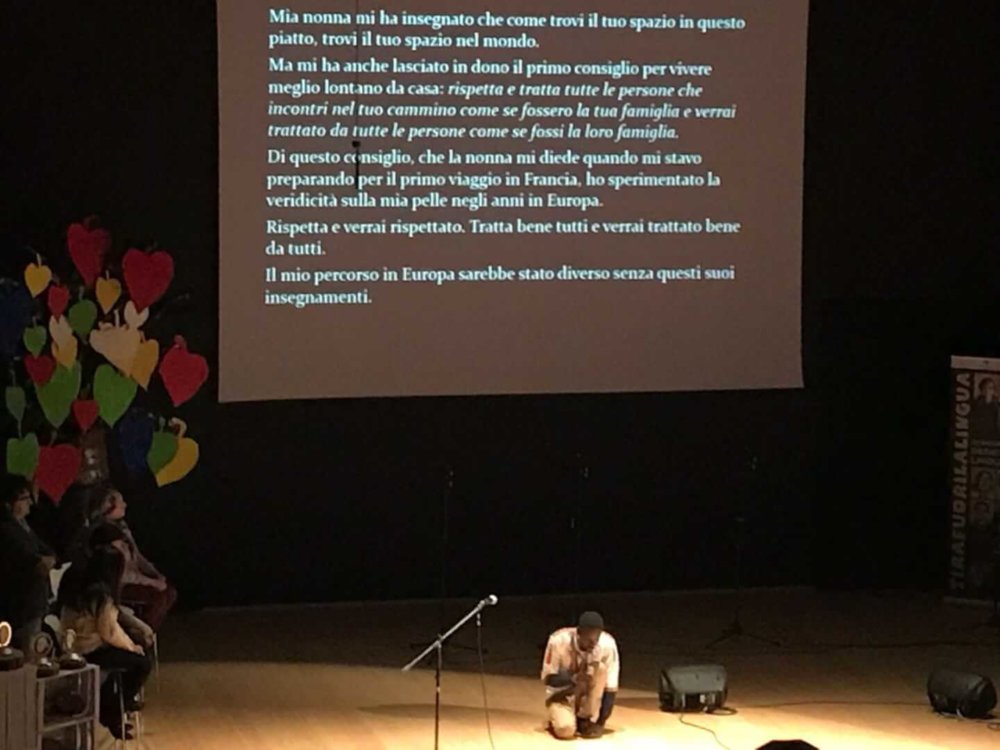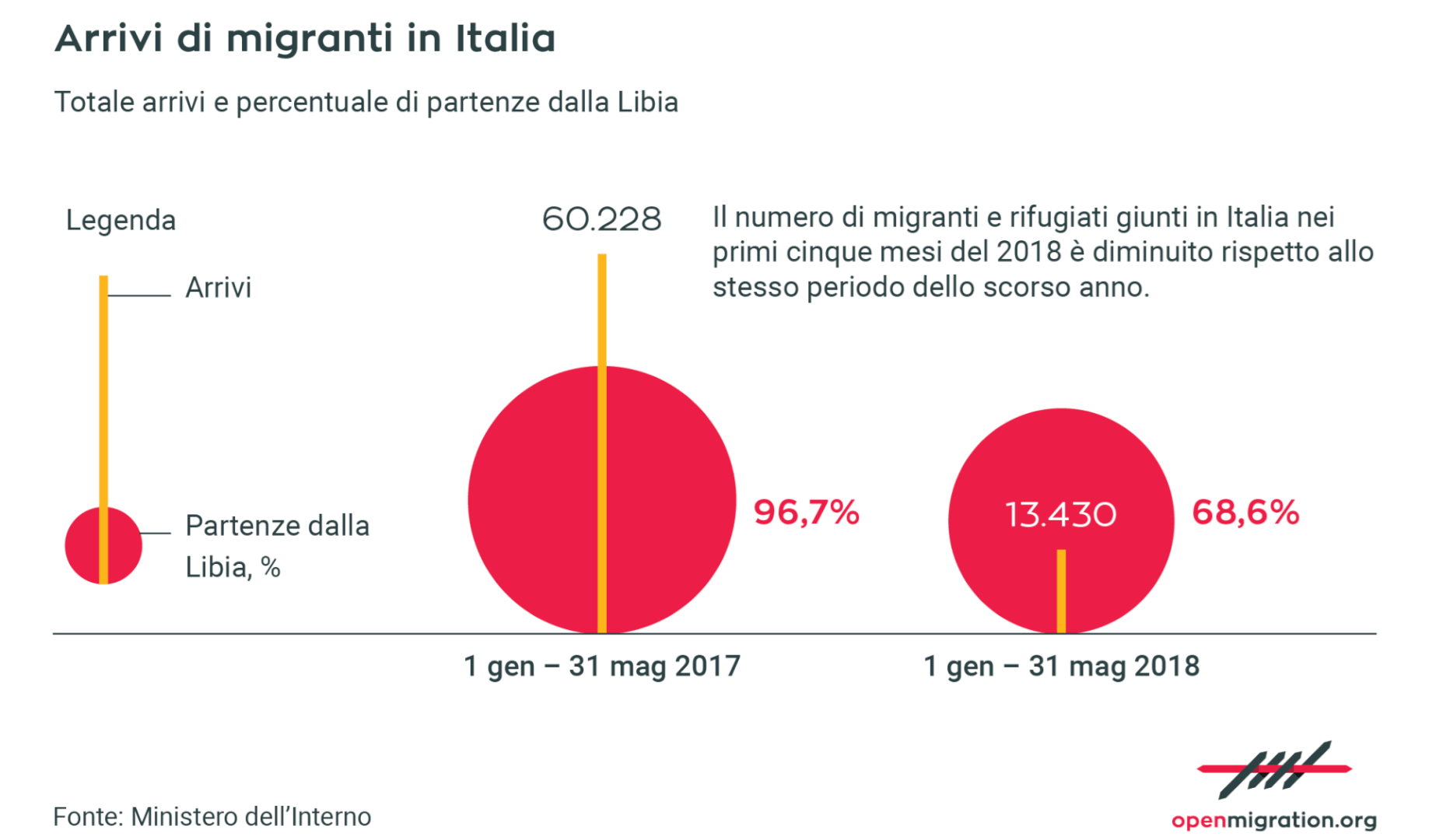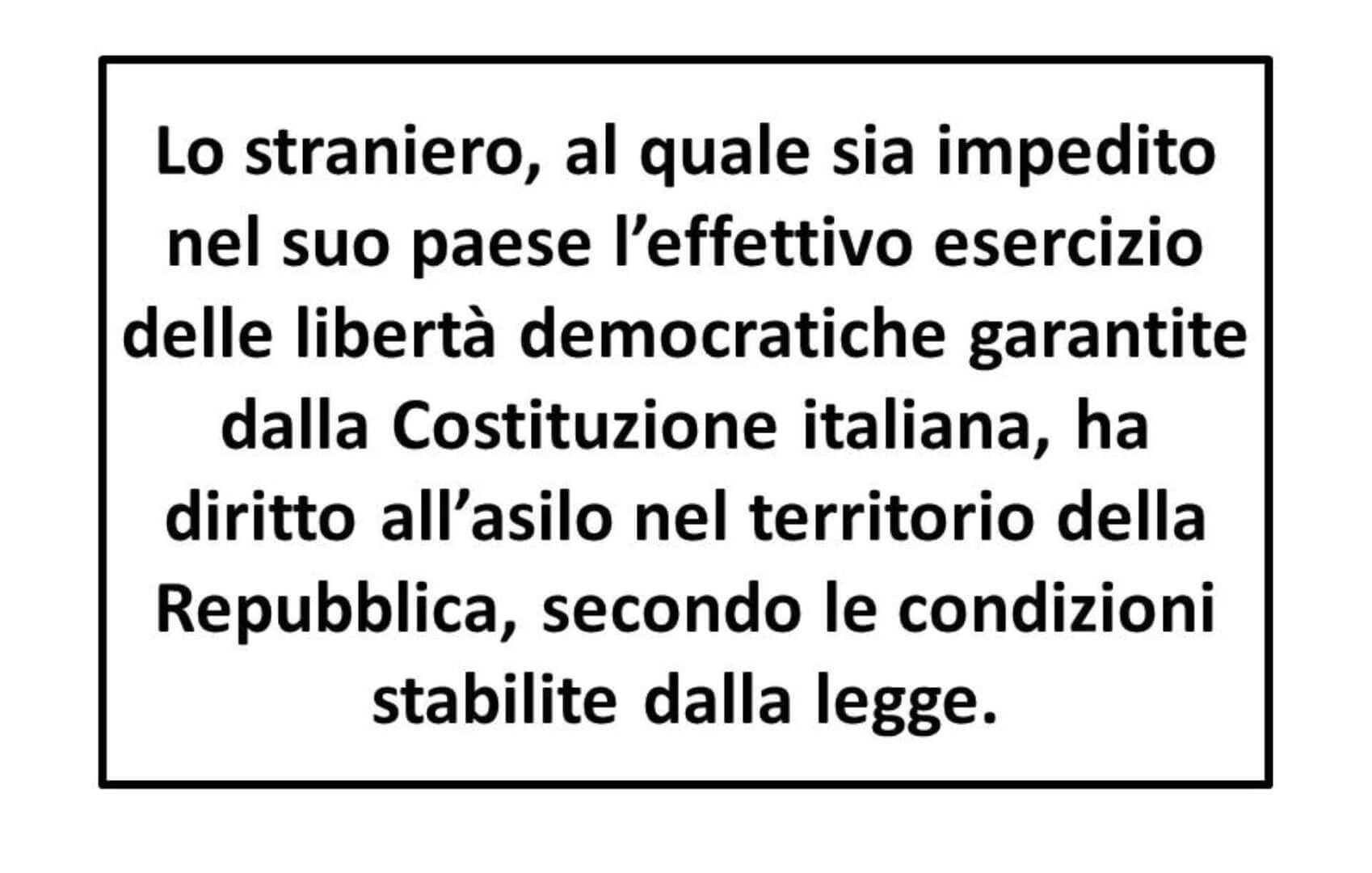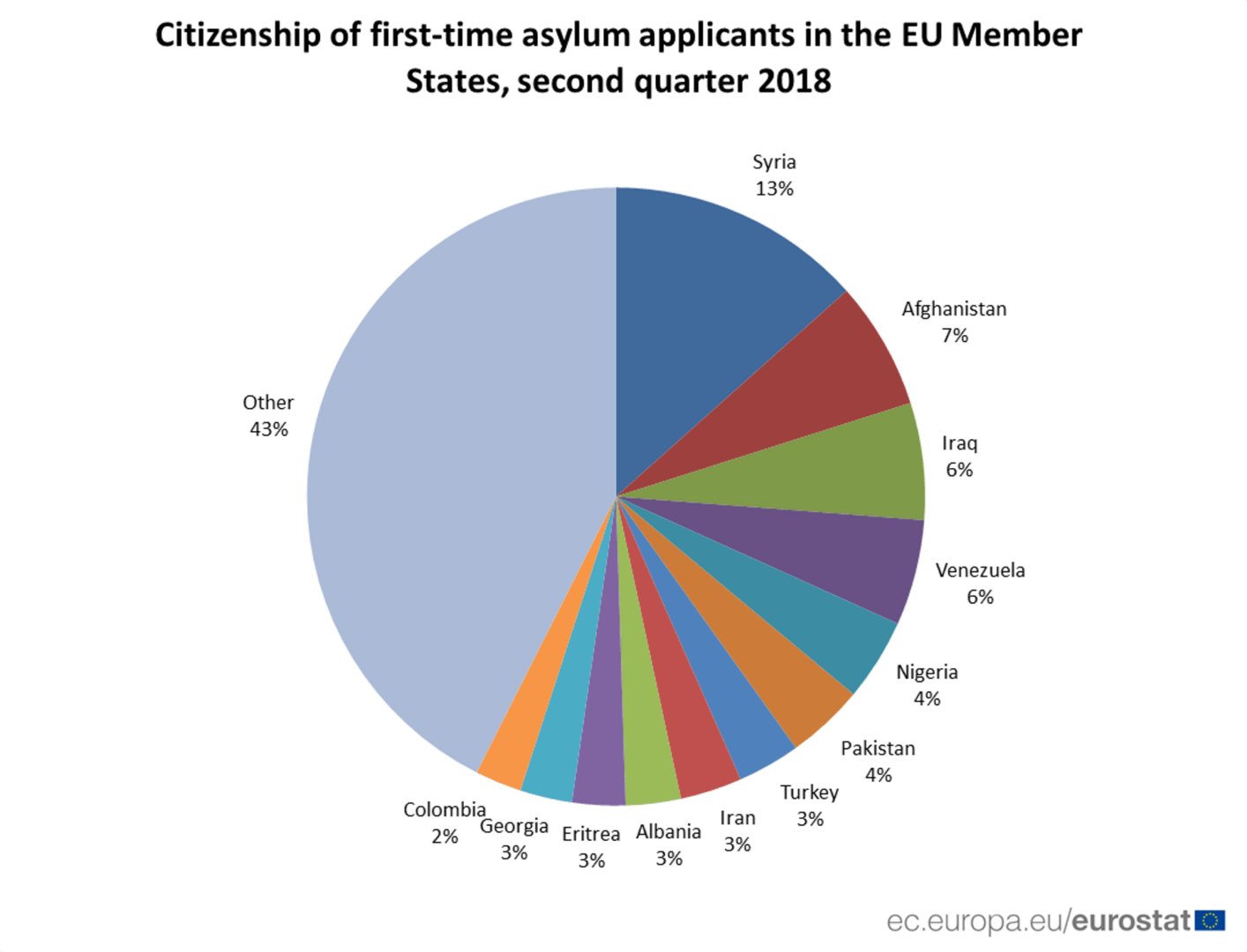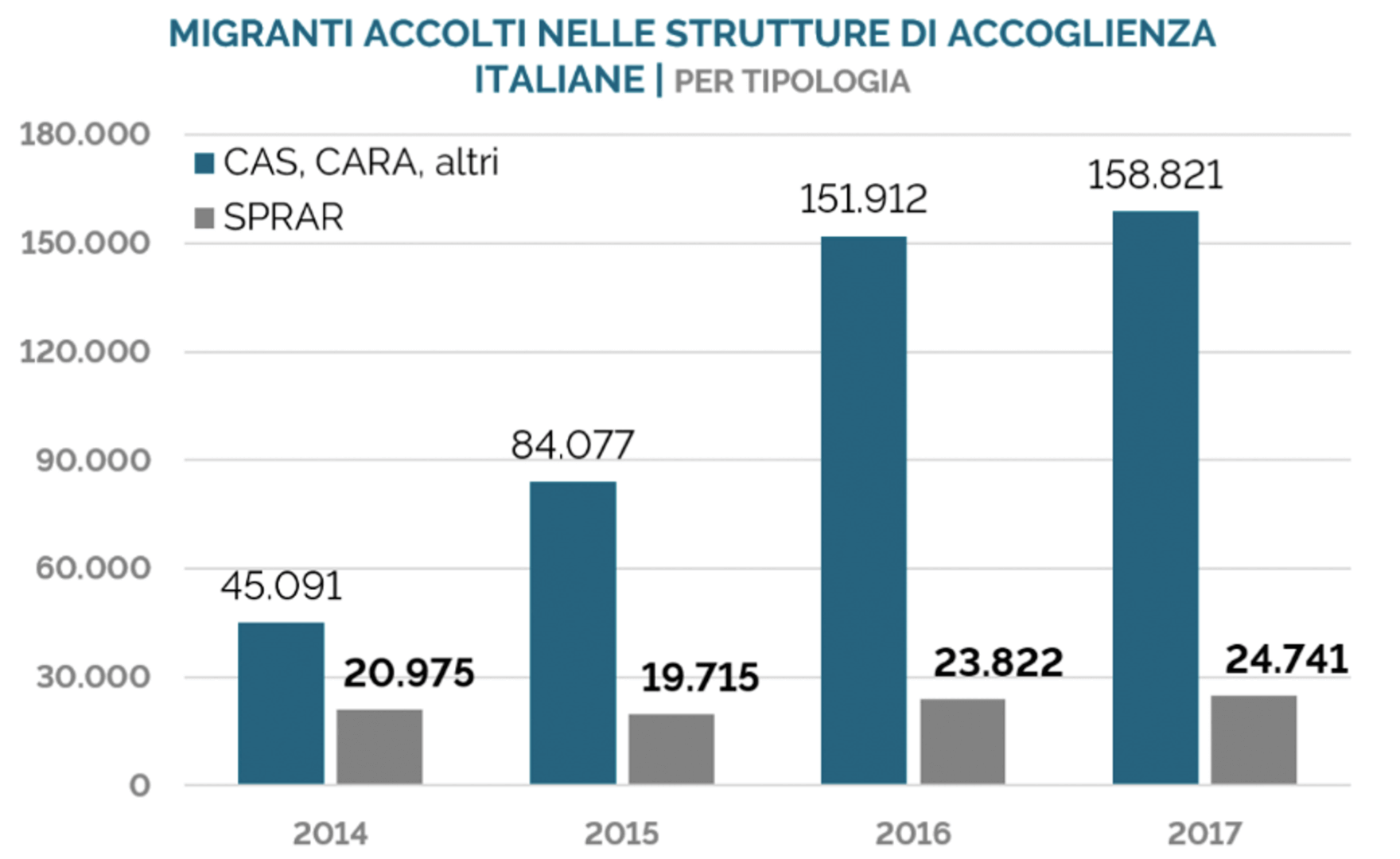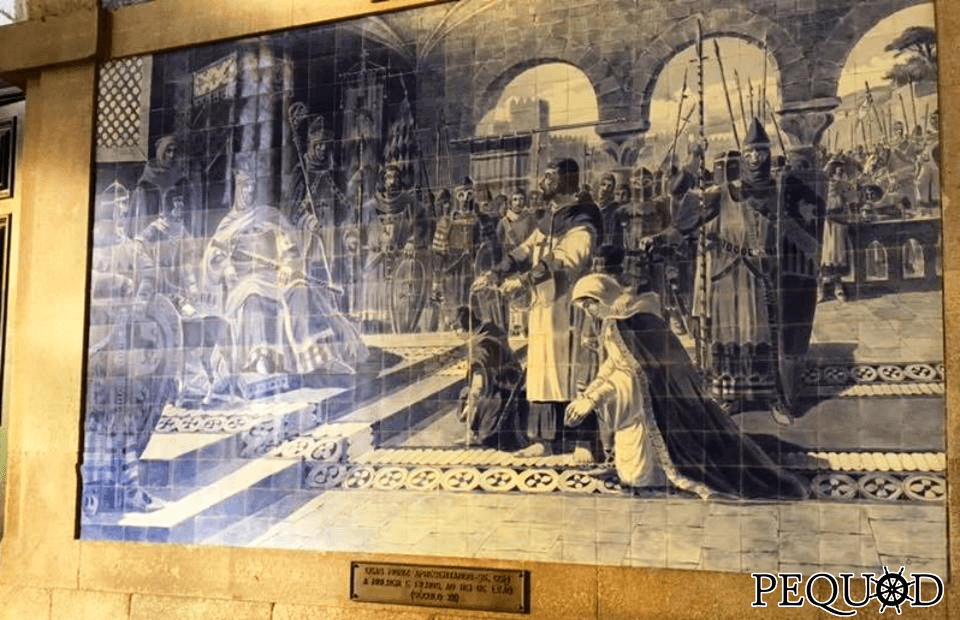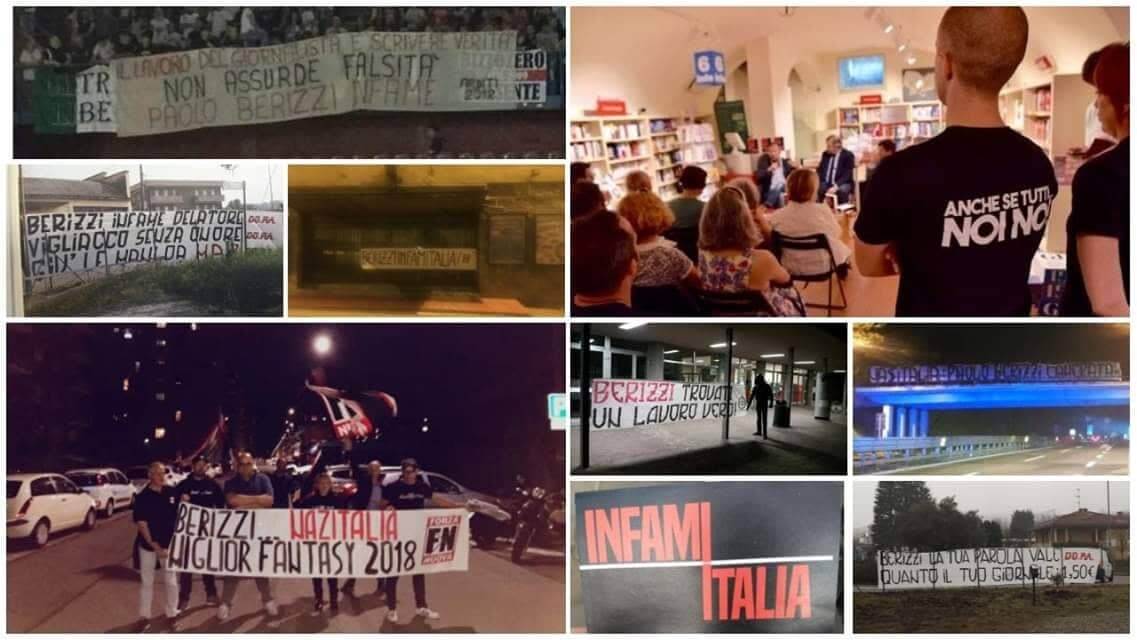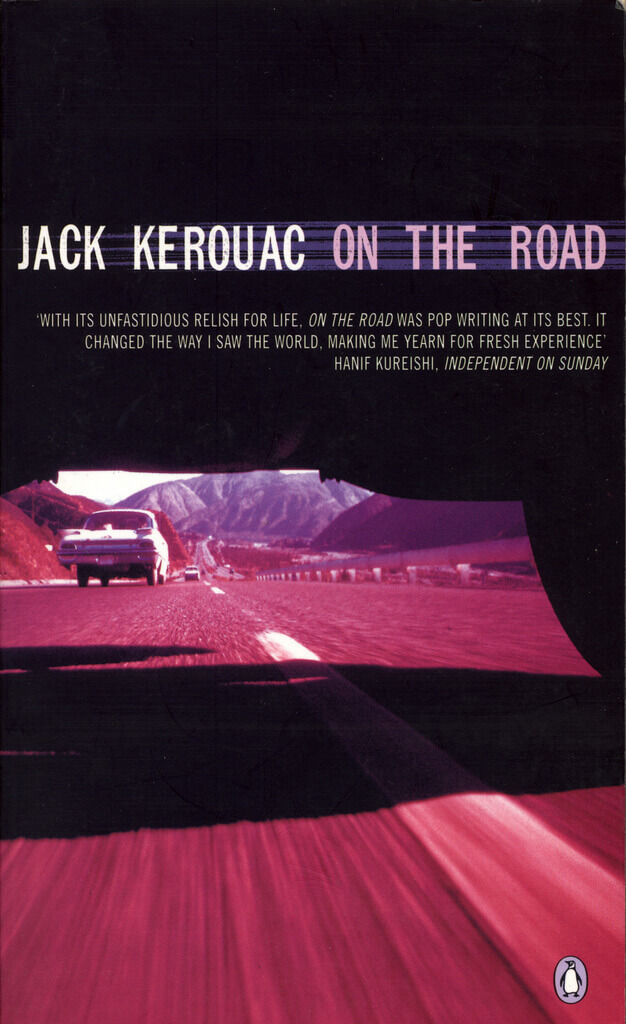Sister Group: il nostro femminismo è antirazzista
Ventimiglia è simbolo degli ermetici confini Europei, la città di confine dove Progetto 20K ha iniziato a operare dal 2016. Oltre al supporto generale alle persone in transito, grazie anche all’ apertura di Eufemia – Info and Legal Point, nasce negli ultimi anni il Sister Group: gruppo femminista nato dall’ esigenza di dedicare spazi specifici alle donne migranti.
Apriamo l’intervista con una domanda che le stesse attiviste si sono poste: «Quali relazioni esistono tra la violenza dei confini e la violenza di genere, che anche noi attiviste sentiamo sulla nostra pelle?». Altra presa di posizione chiave, sottolinea ancora il concetto di sopra: «Il nostro 8 marzo è contro la Legge Salvini, contro la chiusura dei porti, per un Permesso di Soggiorno Europeo slegato dal lavoro e dalla famiglia».
Proprio questa ricerca di intrecci, tra tematiche ampie e complesse si muove il Sister Group: «Un gruppo di attiviste di Progetto 20K e NUDM Genova, in tempi e per ragioni diverse ci siamo avvicinate al contesto di Ventimiglia». Le attiviste ricordano bene le «settimane di monitoraggio sui confini, di manutenzione di sentieri, aiuto materiale e informativo alle persone migranti, ecc… Tutte attività che ci hanno consentito di cominciare a capire qualcosa delle dinamiche del confine».

Le attiviste ci raccontano la brutalità del contesto e quella voglia di realizzare un luogo veramente alternativo e solidale, generatrice di interazioni: dall’assenza di possibilità al costruirne una insieme alle persone in viaggio. Continuano le ragazze: «A novembre del 2017 le donne che vivevano sotto il ponte nell’accampamento informale erano sempre più numerose: molte non volevano stare al campo istituzionale della Croce Rossa, troppo lontano e troppo militarizzato. Iniziava a fare freddo e insieme alle donne c’erano bimbe e bimbi piccolissimi, addirittura neonati. Vedevamo che le donne venivano all’Info Point, ma con evidenti difficoltà: se ne stavano relegate in un angolo e il loro turno alla postazione internet veniva sempre dopo quello degli uomini» .
Riusciamo a comprendere quale è stato il percorso di questo progetto nel contesto di confine e all’ interno di Progetto 20K, scoprendone la nascita e l’evoluzione, fino ad arrivare alle attività. «Il Sister Group è nato a fine novembre del 2017 e ha interrotto le attività a dicembre del 2018: Eufemia non esiste più, abbiamo avuto lo sfratto. Come modello esistiamo ancora, siamo convinte della sua utilità e riproducibilità: ha portato l’approccio e la politica femminista all’interno di un progetto politico fatto da maschi e femmine, che sicuramente era predisposto a lasciarsi contaminare, ma non ancora femminista».

Concretamente? Spiegano le attiviste: «Quando Eufemia era in attività, le donne potevano lavarsi, cambiarsi gli abiti e recuperare materiale utile per l’igiene; usare internet e caricare il cellulare, avere informazioni sulla situazione al di qua e al di là della frontiera, sui servizi sanitari del territorio e sui loro diritti; potevano rilassarsi ascoltando musica, facendosi a vicenda unghie e capelli, affidando per qualche ora le figlie e i figli alle volontarie. Era un posto dove ritrovare un barlume di normalità, dove recuperare un poco di energia e fiducia reciproca e dove condividere speranze e ostacoli».
La peculiarità delle attività è anche avere occhi e orecchie anche per le strade di questa peculiare città di confine, cioè nei luoghi dove la violenza è particolarmente brutale. «Avevamo una particolare attenzione a ciò che accadeva fuori da Eufemia: tante donne arrivano già sotto controllo del racket della tratta e queste donne sono difficilmente avvicinabili: arrivano e subito scompaiono. Abbiamo cercato di monitorare questi movimenti clandestini per capire come provare a intercettare e aiutare queste donne – tra loro tante minori», mi spiegano le attiviste.
Questa attenzione si coglie anche dalla localizzazione fisica che aveva l’ Infopoint di Progetto 20k nel suo complesso, cosi spiegato dal gruppo: «Abbiamo aperto il Sister Group all’interno dell’ Infopoint Eufemia, situato in posizione strategica: a cinque minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Ventimiglia e a un passo dall’accampamento informale sul greto del fiume Roya. Un giorno a settimana lo spazio era aperto esclusivamente a donne e bambine/i».
Diverse attiviste, essendo liguri, vedono questo confine come primario nella loro azione politica: «Ventimiglia era la nostra frontiera: da anni vedevamo le violazioni sulla pelle delle persone migranti, l’ostilità o totale cecità della cittadinanza e delle istituzioni, vedevamo quanto questo danneggiasse anche noi, italiane magari, ma con pelli di diverso colore e con il bisogno di cambiare la società a beneficio del 99% della popolazione mondiale. Era però difficile capire come intervenire, come incontrare le persone migranti. L’ infopoint Eufemia, aperto da Progetto 20K ci dava una base fisica e pratica per lavorare sul territorio e in particolare per noi con le donne e le/i minori».
La mancanza di uno spazio fisico riduce notevolmente le possibilità d’azione, ma ancora una volta la riflessione delle attiviste è profonda e laboratoriale. Valorizzando l’autodeterminazione dei corpi delle donne migranti, «ricominciando le attività, trovando un luogo adatto. Se questo non fosse possibile, di dovrà riorganizzare il lavoro orientato alla relazione con le donne in maniera differente. Abbiamo delle ipotesi ma dobbiamo darci il tempo di sperimentarle e verificarle».

Concludendo, Sister Group porterà l’8 marzo, data dello sciopero femminista globale, anche la questione migratoria, «perché il nostro femminismo parla al 99% della popolazione mondiale, quindi non può che essere antirazzista. In Italia, ma non solo, assistiamo a una campagna di odio contro le persone migranti, diventate ormai il capro espiatorio per ogni male sociale.
Vediamo come siano le donne migranti a pagare il prezzo più alto di questo razzismo diffuso: perché la protezione umanitaria non può essere rinnovata e vengono sbattute fuori dalle accoglienze anche se incinte, anche se con minori. Quando diciamo “sorella non sei sola” lo diciamo a tutte le donne che hanno deciso di cambiare la loro vita, di cercare una strada di libertà e autonomia, ma costantemente si scontrano con la violenza dei confini, dell’economia, del sessismo».

Ph credits: Progetto 20k, NUDM Genova